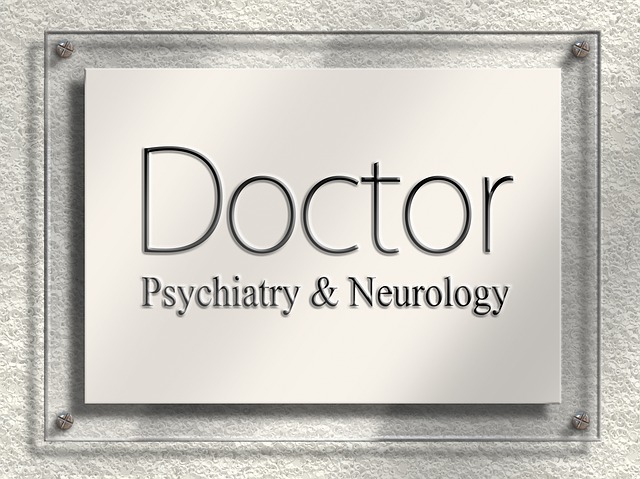Il pregiudizio negativo sugli psicofarmaci è ancora piuttosto diffuso. Le persone, in genere, non hanno alcun problema a riferire di essersi sottoposte ad un ciclo di antibiotici per una grave bronchite o di aver assunto antiacidi per un attacco di gastrite acuta, mentre se hanno dovuto prendere psicofarmaci, preferiscono evitare di parlarne, almeno con chi non è di famiglia e comunque ne riferiscono solo in sede di visita medica.
Questo atteggiamento è frutto di un diffuso punto di vista secondo cui, mentre la malattia organica è qualcosa di estraneo alla nostra persona, il disturbo mentale è invece un modo doloroso di esprimersi della nostra identità: in altre parole è una parte malata di noi stessi, quella parte che svela le nostre fragilità e di cui, perciò, ci vergogniamo, tendendo a nasconderla. Aver assunto psicofarmaci significa non essere riusciti a far fronte da soli alle nostre debolezze che, quindi, risultano aggravate agli occhi degli altri, facendoci apparire vulnerabili e indifesi.
E, invece, anche se è difficile crederlo, i disturbi emotivi dipendono da quella parte dell’apparato neurologico preposta alla elaborazione dell’affettività che, in caso di disfunzioni, trasforma le emozioni in sensazioni spiacevoli, i sintomi appunto; allo stesso modo in cui, l’apparato gastroenterico trasforma i cibi in sostanze più semplici e assimilabili dall’organismo o gli emuntori trasformano le tossine in sostanze facilmente eliminabili tramite il filtro renale o epatico. Potrà sembrare una visione un po’ banale della nostra identità psicoemotiva, ma decenni di ricerche biochimiche hanno dimostrato che tutti i disturbi psichici più gravi dipendono da eccesso o difetto di sostanze chiamate neurotrasmettitori, quasi tutte identificate con certezza, come la noradrenalina, la serotonina, l’acetilcolina, la dopamina ed altre, proprio come l’eccesso di secrezione acida provoca l’ulcera peptica o il difetto di insulina dà luogo al diabete.
Ne consegue che l’uso di psicofarmaci il cui effetto biochimico consiste, appunto, nel modificare l’effetto dei neurotrasmettitori, non solo è indicato in taluni disturbi meno gravi come l’ansia o la depressione lieve, ma addirittura indispensabile nei disturbi più gravi come la psicosi o il disturbo bipolare nei quali l’alterazione psichica primaria può essere talmente grave da provocare disturbi del comportamento non compatibili con la vita familiare o con le aspettative della collettività di appartenenza.
Ecco perché non solo non bisogna temere gli psicofarmaci, ma è necessario sollecitarne la prescrizione, possibilmente da parte di uno specialista, quando i disturbi superino le capacità di essere tollerati da parte del paziente stesso o del suo contesto familiare. E bisogna tenere presente che ognuno di noi, nessuno escluso, ha il suo limite di rottura, superato il quale, il ricorso agli psicofarmaci non solo è legittimo, ma diventa anche un segnale di consapevolezza dei propri limiti e, dunque, di un equilibrio emotivo complessivamente buono che, con queste premesse, sarà facile recuperare.
Articolo di: Giuseppe Magnarapa