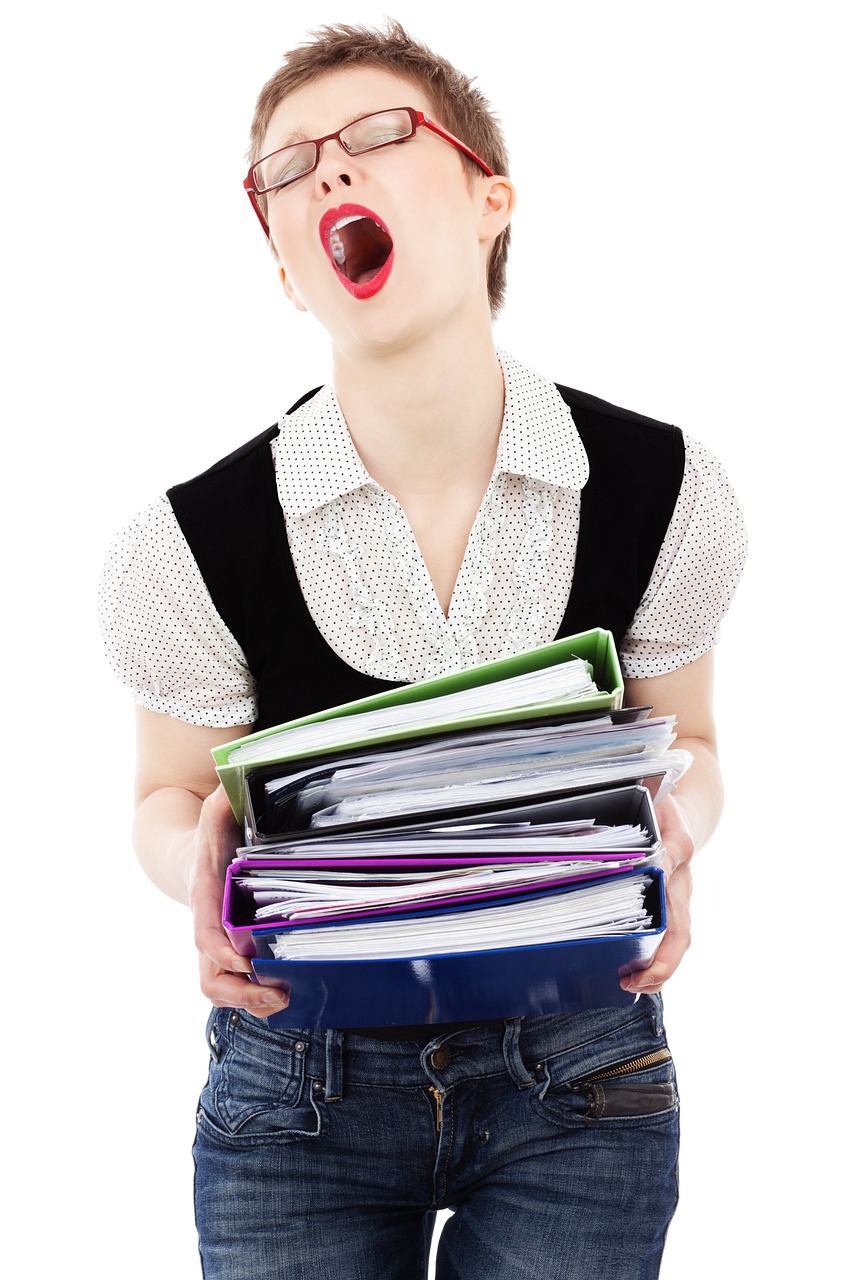Nella società del XXI secolo, accanto alle forme già studiate di dipendenza, compaiono le cosiddette “New Addictions” che comprendono tutte quelle forme di dipendenza in cui l’oggetto è un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata. Per la maggior parte delle persone queste attività sono parte integrante del normale svolgimento della vita quotidiana e talvolta rappresentano una forma di “aiuto” in particolari situazioni di stress, ma per alcuni individui possono assumere caratteristiche patologiche fino a provocare gravissime conseguenze come la compromissione delle relazioni interpersonali, del funzionamento scolastico o lavorativo, del tempo libero, della salute fisica e psichica.
Tra i principali tipi di dipendenza comportamentali si annoverano quelle da esercizio fisico, da cibo, da lavoro, dalle tecnologie e in particolare da Internet. Il mondo della rete è entrato a far parte della vita quotidiana di milioni di persone ormai da tempo, rappresenta di sicuro un’importante risorsa ma se mal gestita può diventare un pericolo e l’abuso può trasformarsi in una vera e propria dipendenza. La Dipendenza da Internet (IAD, Internet Addiction Disorder) il cui termine è stato coniato nel 1995 da Ivan Goldberg psichiatra e docente alla Columbia University di New York, nel 2013 è stata inserita nel DSM-V come diagnosi sperimentale.
La IAD racchiude in sé diverse forme e sottocategorie legate alla tecnologia e al mondo della rete:
• game, dipendenza dai videogiochi di rete;
• sex, dipendenza dalla visione e scambio di materiale pornografico e dalla frequentazione di chat per soli adulti;
• social networks, dipendenza dalle relazioni interpersonali virtuali;
• info surfing, dipendenza dalla continua ed estenuante ricerca di notizie su internet;
• net compulsion, dipendenza dallo shopping online, dalle aste online, da eBay, dal trading finanziario;
• gambling, dipendenza dal gioco d’azzardo online.
La dipendenza dalla rete passa attraverso tre fasi:
• il coinvolgimento (per curiosità, gratificazioni emozionali, sensoriali, culturali, sociali)
• la sostituzione (le nuove tecnologie sostituiscono ciò che manca o è inaccessibile nella vita reale)
• la fuga (diventa un antidoto efficace a stress e sofferenza; in questa fase si instaura la dipendenza).
La dinamica della dipendenza tecnologica sembra centrata sull’impellenza del desiderio, sull’immediatezza della gratificazione e la necessità della realizzazione in tempo reale. Le strategie di trattamento possono essere diverse a seconda del tipo di disagio in cui si è coinvolti. Si può intervenire attraverso i gruppi di auto-aiuto, la psicoterapia individuale e il counseling terapeutico.
I giovani (i cosiddetti nativi digitali) risultano particolarmente adattabili ai nuovi dispositivi tecnologici ma sono anche i più vulnerabili alla dipendenza specie in adolescenza, fase in cui la struttura della personalità dell’individuo è in fase di consolidamento ed espansione. A tal proposito sarebbe importante promuovere attitudini “sane” nei confronti delle nuove tecnologie, attraverso il processo educativo familiare e scolastico per favorire quindi una vera e propria cultura dell’utilizzo evidenziando anche i numerosi fattori positivi.